Introduzione
L’emocromatosi è una malattia in cui si verifica un accumulo eccessivo di ferro nell’organismo (sovraccarico), tanto da diventare tossico e quindi pericoloso.
Tra i sintomi più comuni della condizione si annoverano:
- stanchezza,
- perdita di peso,
- dolori articolari,
- disfunzione erettile negli uomini,
- alterazioni del ciclo mestruale nelle donne.
Il metallo può accumularsi nella maggior parte degli organi, ma si rileva in particolare un’eccessiva deposizione in 3 organi nobili:
- L’eccesso di ferro nel fegato può causarne il rigonfiamento, insufficienza epatica, tumore o la cirrosi (una condizione caratterizzata dalla formazione di cicatrici all’interno dell’organo, che ne determinano il malfunzionamento).
- L’eccesso di ferro nel cuore può causare irregolarità del battito (aritmie) e arresto cardiaco.
- L’eccesso di ferro nel pancreas, invece, può causare la comparsa di diabete.
Esistono due tipi di emocromatosi, quella primaria e quella secondaria.
- La forma primaria è causata da un difetto dei geni che controllano la quantità di ferro assorbita dagli alimenti.
- La forma secondaria di solito è provocata da un’altra patologia o da un altro disturbo che causa il sovraccarico di ferro.
La maggior parte dei pazienti affetti da emocromatosi primaria eredita il disturbo dai genitori. Se i geni ereditati sono due (uno da ciascun genitore), si rischia di andare in sovraccarico di ferro e di manifestare i segni e i sintomi del disturbo. I due geni difettosi fanno assorbire all’organismo più ferro del normale dagli alimenti. Il portatore ha invece ereditato un solo gene difettoso e non rischia un sovraccarico di ferro
Non tutti i pazienti affetti da questa alterazione genetica manifestano i segni o sintomi della patologia, si stima infatti che circa la metà dei pazienti malati non presenti in realtà alcun disturbo.
Anche la gravità con cui colpisce può variare sensibilmente:
- alcuni pazienti non presentano complicazioni anche se il livello di ferro nel loro organismo è molto elevato,
- altri invece iniziano a soffrire di complicazioni gravi o addirittura fatali.
Esistono diversi fattori in grado di influire sulla gravità della patologia, ad esempio
- un apporto elevato di vitamina C può far peggiorare la malattia, perché questa molecola favorisce l’assorbimento del ferro,
- l’assunzione di alcol può far peggiorare le lesioni al fegato e la cirrosi causati dall’emocromatosi e altri disturbi come l’epatite possono danneggiare o indebolire ulteriormente il fegato.
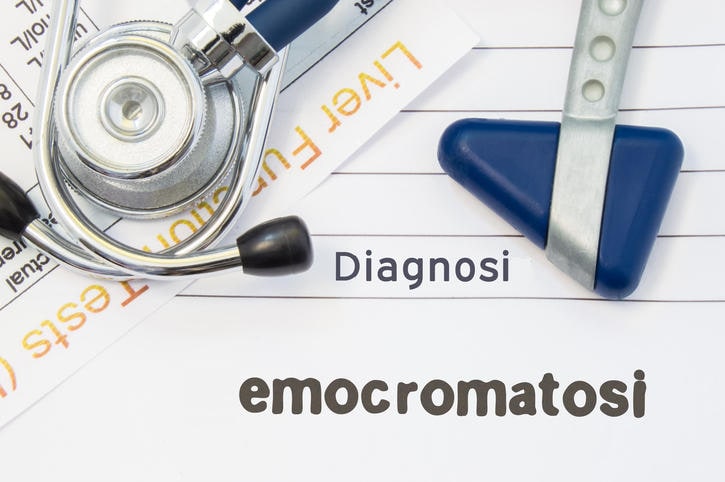
iStock.com/Shidlovski
Cause
Esistono due forme di emocromatosi: quella primaria e quella secondaria. Le cause sono diverse a seconda della forma che colpisce il paziente.
Emocromatosi primaria
La forma primaria (genetica) è causata da un’anomalia dei geni che controllano la quantità di ferro assorbita con l’alimentazione. Questa forma del disturbo in alcuni casi è detta emocromatosi ereditaria o classica ed è la più comune.
I geni connessi si chiamano HFE: i geni HFE difettosi fanno assorbire all’organismo una quantità eccessiva di ferro. Se il paziente eredita due copie del gene HFE difettoso (una da ciascun genitore), rischia il sovraccarico di ferro e i sintomi della malattia.
Se il paziente eredita un gene HFE difettoso e uno normale, diventa portatore sano, una condizione in cui non si sviluppano i sintomi della malattia, ma si può verificare la trasmissione del gene difettoso ai propri figli. Le stime indicano che negli Stati Uniti una persona su dieci è portatrice del gene della malattia.
Se i due genitori sono entrambi portatori sani del gene HFE difettoso, i loro figli hanno
- il 25 per cento di probabilità di ereditare entrambi i geni HFE difettosi,
- il 50% di diventare a loro volta portatori sani,
- il 25% di ereditare solo copie corrette dei geni.
L’emocromatosi può essere causata anche da altri geni, ma si tratta situazioni meno frequenti e la valutazione di tutti i diversi casi possibili va al di là dello scopo di questo articolo; per approfondire si segnala invece la seguente risorsa.
Emocromatosi secondaria
La forma secondaria di norma è provocata da una diversa condizione in grado di causare il sovraccarico di ferro, tra cui per esempio:
- alcune forme di anemia, come la talassemia e l’anemia sideroblastica,
- l’atransferrinemia e l’aceruloplasminemia (malattie ereditarie rare),
- patologie epatiche croniche, come l’epatite C cronica, le patologie del fegato causate dall’alcol o la steatoepatite non alcolica.
L’emocromatosi secondaria può anche essere causata da altri fattori, come ad esempio:
- trasfusioni di sangue,
- sovradosaggio da integratori di ferro,
- dialisi prolungata.
Fattori di rischio
Il fattore di rischio principale è ovviamente la presenza di due geni HFE difettosi, ereditati uno da ciascun genitore; tuttavia molti dei pazienti che hanno due copie del gene difettoso non sviluppano alcun sintomo della malattia.
L’emocromatosi è una delle patologie genetiche più comuni; le manifestazioni della malattia sono fino a 10 volte più frequenti nei pazienti di sesso maschile, in quanto l’espressione genica viene influenzata da fattori esterni quali la dieta (e il relativo contenuto in ferro), le perdite ematiche associate a mestruazioni e gravidanza, le donazioni di sangue, …
I sintomi generalmente non si manifestano negli uomini prima dei 40-60 anni, mentre nelle donne è raro diagnosticarla prima dei cinquant’anni d’età (in corrispondenza della menopausa). I casi di emocromatosi nei bambini sono molto rari e il rischio di complicazioni è maggiore tra gli anziani.
L’alcolismo è un altro fattore di rischio per l’emocromatosi. Anche i precedenti familiari di determinati disturbi e patologie fanno aumentare il rischio di soffrire di emocromatosi. Tra questi disturbi e patologie ricordiamo: l’infarto, le malattie epatiche, il diabete, l’artrite e la disfunzione erettile (impotenza).
Sintomi
L’emocromatosi può colpire diverse parti dell’organismo e causare segni e sintomi differenti, purtroppo spesso in forma aspecifica (simili a quelli di altre patologie).
I sintomi di solito non si verificano fino all’età adulta, esordendo in genere tra i 30 e i 60 anni.
- Le donne hanno maggiori probabilità che i sintomi generici, come la stanchezza, compaiano per primi.
- Negli uomini, le complicazioni come il diabete o la cirrosi (cicatrici nel fegato) spesso sono i primi sintomi della patologia.
I sintomi variano a seconda della gravità della malattia, tra quelli più frequenti ricordiamo:
- il dolore articolare,
- la stanchezza,
- la debolezza,
- il dimagrimento,
- il mal di stomaco e dolore addominale,
- disfunzione erettile negli uomini,
- alterazioni del ciclo mestruale nelle donne (oligomenorrea ed amenorrea).
Non tutti i pazienti affetti presentano i sintomi della malattia. Le stime sul numero di pazienti che presentano i sintomi sono molto variabili, alcune indicano che la metà circa dei pazienti malati non presenta alcun sintomo.
Con il progredire della malattia, a causa dell’instaurarsi di complicazioni, possono comparire:
- ittero,
- aumento della sete,
- dolore al petto,
- affanno,
- gonfiore di mani e piedi,
- battito cardiaco irregolare (aritmie).
Pericoli
La prognosi per i pazienti affetti da emocromatosi dipende in gran parte dalle lesioni agli organi già presenti al momento della diagnosi, quindi è molto importante un riconoscimento precoce, che consente al paziente di poter condurre una vita normale.
Se invece la malattia non viene curata tempestivamente può causare gravi lesioni agli organi e persino il decesso del paziente, a causa di complicazioni legate all’accumulo di ferro:
- malattie del fegato, come
- epatomegalia (ingrossamento del fegato),
- insufficienza epatica,
- tumore del fegato,
- cirrosi (formazione di cicatrici nel fegato),
- problemi cardiaci, come
- aritmie (irregolarità del battito),
- arresto cardiaco,
- diabete, soprattutto nei pazienti con precedenti famigliari,
- lesioni e dolori articolari, come l’artrite,
- problemi dell’apparato riproduttore, come
- disfunzione erettile (impotenza), riduzione del volume dei testicoli e la perdita di desiderio sessuale negli uomini,
- assenza del ciclo mestruale e la menopausa precoce nelle donne,
- alterazioni del colore della pelle (pelle grigiastra o di colore bronzeo),
- scarsa attività dell’ipofisi e della tiroide,
- lesioni delle ghiandole surrenali.
Diagnosi
Il medico diagnostica l’emocromatosi basandosi sulla storia medica del paziente e della sua famiglia, sulla visita e sui risultati degli esami.
In alcuni casi può essere diagnosticata durante controlli per altre patologie, come l’artrite, le patologie del fegato, il diabete, le patologie cardiache o la disfunzione erettile (impotenza).
Specialisti coinvolti
La diagnosi e la cura della malattia spettano al medico di famiglia e agli internisti. Anche altri medici possono essere coinvolti nella diagnosi e nella cura dell’emocromatosi, ad esempio:
- ematologo (specialista delle malattie del sangue),
- cardiologo (specialista nelle malattie del cuore),
- endocrinologo (specialista nelle malattie delle ghiandole),
- epatologo (specialista nelle malattie del fegato),
- gastroenterologo (specialista nelle malattie dell’apparato digerente),
- reumatologo (specialista nelle malattie delle articolazioni e dei tessuti).
Anamnesi personale e famigliare
Per l’anamnesi personale e famigliare il medico potrà rivolgervi diverse domande relative a:
- segni e sintomi, momento della loro comparsa e gravità;
- assunzione di integratori di ferro (in compresse o tramite iniezioni), accompagnati o meno da integratori di vitamina C (la vitamina C aiuta l’organismo ad assorbire il ferro presente negli alimenti). Il medico potrà chiedervi quanto ferro assumete: quest’informazione potrà essergli utile per diagnosticare l’emocromatosi secondaria;
- presenza di altri membri della famiglia affetti dall’emocromatosi;
- eventuali patologie o problemi connessi che hanno colpito i vostri famigliari.
Visita
Il medico vi visiterà per controllare eventuali sintomi.
Ausculterà il cuore per escludere eventuali aritmie e vi controllerà, per escludere eventuali sintomi dell’artrite, le alterazioni del colore della pelle e l’epatomegalia.
Esami diagnostici
Esami del sangue
Nei pazienti affetti da emocromatosi ci può essere un eccesso di ferro nell’organismo, ma la quantità di ferro presente nel sangue può essere normale, per questo è necessario ricorrere ad esami specifici:
- saturazione della transferrina,
- ferritina sierica,
- esami della funzionalità epatica.
La transferrina è una proteina che trasporta il ferro nel sangue. L’esame indica la quantità di ferro trasportata dalla transferrina e aiuta il medico a scoprire quanto ferro c’è nell’organismo.
Se la transferrina è alta, il medico può anche controllare la ferritina sierica; si tratta di un test economico, facilmente disponibile e minimamente invasivo in grado di consentire una valutazione delle riserve di ferro nell’organismo. Il suo principale limite è la possibilità che aumenti anche in risposta a numerose altre condizioni mediche non correlate ai livelli di ferro, come ad esempio:
- infezione,
- infiammazione,
- febbre,
- malattie del fegato,
- malattie renali
- e tumore.
Per escludere lesioni al fegato al paziente possono essere prescritti esami della funzionalità epatica. Le lesioni al fegato possono essere sintomo dell’emocromatosi. Se sapete già di soffrite di questa malattia, gli esami della funzionalità epatica sono in grado di indicare la gravità della patologia.
Gli esami del sangue, da soli, non servono per una diagnosi definitiva, quindi il medico può consigliarvi di eseguire anche altri tipi di esami.
Biopsia del fegato
In caso di biopsia del fegato, il medico esegue l’anestesia locale e poi rimuove un piccolo campione di tessuto epatico usando una siringa. Il tessuto poi viene esaminato al microscopio.
La biopsia del fegato può indicare la quantità di ferro presente nell’organo. Quest’esame inoltre può aiutare il medico a diagnosticare le patologie del fegato (come la cirrosi o i tumori). Le biopsie del fegato vengono eseguite con minore frequenza rispetto al passato.
Risonanza magnetica
La risonanza magnetica è una tecnica d’esame non invasiva che usa le onde radio, grandi calamite e un computer per elaborare immagini degli organi interni. La risonanza magnetica può essere eseguita per avere un’indicazione sulla quantità di ferro presente nel fegato.
Dispositivo superconduttore a interferenza quantistica
Il dispositivo superconduttore a interferenza quantistica (SQuID) è un’apparecchiatura che usa calamite molto sensibili per misurare la quantità di ferro presente nel fegato. Quest’apparecchiatura è disponibile in pochissimi centri specializzati.
Esami genetici
Gli esami genetici possono indicare se il paziente ha uno o entrambi i geni HFE difettosi. Tuttavia, anche se una persona ha due geni HFE difettosi, l’esame genetico non può prevedere se inizierà a soffrire dei sintomi dell’emocromatosi.
Inoltre gli esami genetici potrebbero non essere in grado di individuare altri geni difettosi che, in rari casi, possono essere responsabili della malattia.
Per eseguire gli esami genetici esistono due modalità. Le cellule possono essere raccolte dall’interno del cavo orale usando un tampone oppure può essere prelevato un campione di sangue dal braccio.
Chi soffre di emocromatosi (o ha precedenti famigliari di questa patologia) e desidera un figlio può prendere in considerazione la possibilità di eseguire gli esami genetici e una consulenza genetica. Gli esami possono essere utili per capire se uno o entrambi i genitori possiedono uno o entrambi i geni HFE difettosi. Il consulente genetico può capire se i genitori rischiano di trasmettere i geni difettosi in eredità ai figli.
Cura e terapia
La terapia può servire a
- prevenire,
- alleviare
- o in alcuni casi anche a guarire
le complicazioni della malattia, nonché a consentire una migliore qualità della vita.
Le terapie comprendono la flebotomia terapeutica, la terapia ferrochelante, le modifiche della dieta e le terapie per le complicazioni.
Tra gli scopi della terapia ricordiamo principalmente:
- riduzione della quantità di ferro presente nell’organismo fino a livelli normali,
- prevenzione o rallentamento delle lesioni agli organi dovute al sovraccarico di ferro,
- terapia delle complicazioni,
- mantenimento di una quantità di ferro normale per il resto della vita.
Flebotomia terapeutica
La flebotomia terapeutica è un intervento che rimuove il sangue (e quindi il ferro) dall’organismo. Viene inserito un ago in una vena: il sangue scorre attraverso un tubicino sigillato e raggiunge un contenitore sterile.
Il procedimento è simile a quello della donazione di sangue. La flebotomia può essere eseguita in un centro per le donazioni, in ospedale o in un ambulatorio.
Nella prima fase della terapia, vengono prelevati circa 500 ml di sangue una volta o due alla settimana. Quando i livelli di ferro nel sangue ritornano alla normalità, il paziente in alcuni casi deve ancora continuare le flebotomie; tuttavia la loro frequenza può essere ridotta da tre a sei volte all’anno.
Durante la terapia, che spesso dovrà continuare per tutta la vita, il paziente dovrà eseguire gli esami del sangue frequentemente per controllare i livelli di ferro nel sangue.
Terapia ferrochelante
La terapia ferrochelante usa i farmaci per rimuovere il ferro in eccesso dall’organismo. Questa terapia è una buona alternativa per chi non può sottoporsi regolarmente alle flebotomie.
Il farmaco usato per la terapia ferrochelante viene assunto per via orale o per tramite iniezione. La terapia ferrochelante con iniezioni viene eseguita in ambulatorio, mentre quella orale può essere eseguita a domicilio.
Modifiche della dieta
Se soffrite di emocromatosi, il medico può suggerirvi di modificare la vostra dieta in vari modi, come ad esempio:
- Evitare gli integratori di ferro in qualsiasi forma (prestare attenzione ai multivitaminici, che spesso contengono anche questo metallo).
- Limitare l’apporto di vitamina C, perché aiuta il vostro corpo ad assorbire il ferro presente negli alimenti.
- Evitare il pesce e i crostacei crudi. Alcuni tipi di pesce e di crostacei contengono batteri che causano infezioni nei pazienti affetti da patologie croniche come l’emocromatosi.
- Limitare l’assunzione di alcol. Bere alcol fa aumentare il rischio di patologie del fegato e può far peggiorare le patologie del fegato preesistenti.
Terapia delle complicazioni
Il medico può prescrivere altre terapie in caso di complicazioni, come le patologie del fegato, i problemi cardiaci o il diabete.
È possibile prevenire l’emocromatosi primaria o ereditaria, però non tutti coloro che ereditano i geni sviluppano i sintomi o le complicazioni della patologia. Nei pazienti con complicazioni, le terapie impediscono che la patologia peggiori.
Le terapie comprendono la flebotomia terapeutica, la terapia ferrochelante, le modifiche della dieta e altri tipi di terapie.
Chi soffre della malattia (o ha precedenti famigliari) e desidera un figlio può prendere in considerazione l’opportunità di eseguire esami genetici e di ricevere una consulenza genetica. L’esame può essere utile per indicare se uno o entrambi i genitori sono portatori dei geni HFE difettosi. La consulenza genetica può servire per capire la probabilità che i genitori trasmettano in eredità i geni difettosi ai figli.
Convivere con l’emocromatosi
La prognosi dei pazienti dipende in gran parte dall’estensione delle lesioni agli organi interni già presenti al momento della diagnosi. La diagnosi e la terapia precoci sono perciò fondamentali.
La terapia può essere utile per prevenire, rallentare o in alcuni casi anche guarire le complicazioni della malattia. La terapia inoltre può permettere al paziente di avere più energia e una migliore qualità della vita. Con una diagnosi e una terapia precoci, è possibile condurre una vita normale.
Se si sono già verificate lesioni agli organi interni, la terapia serve per prevenire ulteriori danni e migliorare la speranza di vita, però può non essere in grado di guarire i problemi già insorti.
Se l’emocromatosi non viene curata, può provocare gravi lesioni agli organi interni o addirittura il decesso del paziente.
Dopo la terapia
I pazienti reagiscono in modo molto diverso alla terapia. Alcune persone che devono sottoporsi con frequenza alla flebotomia possono sentirsi molto stanche. Chi ha una malattia avanzata o riceve terapie molto invasive e rimane quindi indebolito può aver bisogno d’aiuto per svolgere le normali attività quotidiane.
All’inizio può essere necessario sottoporsi alla flebotomia con frequenza. La durata di questo tipo di terapia dipende dalla quantità di ferro in eccesso presente nell’organismo.
Dopo il periodo iniziale della terapia probabilmente dovrete sottoporvi alla terapia da due a sei volte all’anno, per impedire che il ferro si accumuli di nuovo.
Terapia continua
Se soffrite di emocromatosi, è importante sottoporsi a una terapia continua. La terapia continua può comprendere:
- flebotomie terapeutiche,
- assunzione di farmaci seguendo la prescrizione medica,
- contatto con il medico in caso di sintomi nuovi, peggioramento dei sintomi o eventuali reazioni avverse alla flebotomia,
- follow-up regolare sui risultati degli esami, sul proseguimento della terapia e sugli esami annuali,,
- uso di un’agenda o di altri strumenti per registrare la quantità di ferro presente nell’organismo.
Se dovete sottoporvi regolarmente alla flebotomia, probabilmente dovrete cambiare gli orari di lavoro per adeguarvi alla terapia. Probabilmente dovrete anche modificare gli orari di lavoro per riprendervi dai periodi di stanchezza, soprattutto se la terapia vi indebolisce molto.
Sostegno emotivo
Convivere con l’emocromatosi può causare
- paura,
- ansia,
- depressione
- e stress.
Parlate dei vostri stati d’animo con i medici che vi seguono oppure con uno specialista. Se siete molto depressi, il medico può consigliarvi di assumere farmaci o di iniziare terapie di altro tipo per migliorare la qualità della vita.
Partecipare a un gruppo di aiuto può aiutarvi ad affrontare meglio la malattia. Potrete vedere come altre persone affrontano sintomi simili o uguali ai vostri. Chiedete al medico o al personale sanitario se esistono gruppi di aiuto nella vostra zona.
Per alleviare lo stress e l’ansia può essere utile anche il sostegno dei famigliari e degli amici. Fate capire a chi vi circonda come vi sentite e che cosa possono fare per aiutarvi.
Screening famigliare
Il medico può consigliarvi di eseguire gli esami genetici per scoprire se i membri della vostra famiglia siano a loro volta portatori o malati. Se a un vostro parente è già stata diagnosticata la malattia, l’esame genetico può indicare se si tratta della forma primaria (ereditaria) della patologia.
Fonti e bibliografia
Le domande più frequenti
Cosa significa un valore elevato di ferritina?
Quali sintomi si manifestano in caso di ferritina alta?
Cosa mangiare in caso di ferritina elevata?
Autore
Dr. Roberto Gindro
DivulgatoreLaurea in Farmacia con lode, PhD in Scienza delle sostanze bioattive.
Fondatore del sito, si occupa ad oggi della supervisione editoriale e scientifica.
